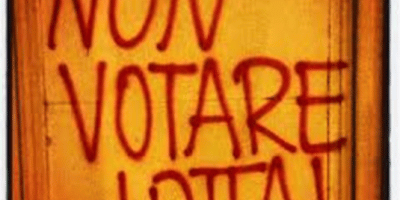Dopo la crisi del No, che fare a sinistra?
Antonello Zecca
12 dicembre 2016
(pubblicato sul sito Anticapitalista.org)
Com’era prevedibile, la borghesia non è rimasta a mani conserte dopo il sonoro schiaffone ricevuto lo scorso 4 dicembre, quando una marea di NO ha travolto il fu governo Renzi.
Nel momento in cui scriviamo, Paolo Gentiloni, già ministro degli esteri in quel governo, è salito al Quirinale per accettare il mandato esplorativo del presidente della Repubblica volto alla formazione di una nuova compagine governativa. Sembra evidente che l’obiettivo di Mattarella sia quello di mantenere una continuità con la precedente esperienza renziana in grado di assicurare una “transizione ordinata” a nuove elezioni politiche che, nei desiderata del capo dello Stato, dovrebbero giungere alla conclusione naturale della legislatura nel 2018, sebbene pare più realistico che le elezioni si terranno dopo il G7 di Taormina del 26/27 maggio prossimi.
Mattarella si sta facendo garante della maggior stabilità possibile del quadro politico nelle nuove condizioni, con l’aiuto determinante del presidente emerito Giorgio Napolitano, autentico regista di questa operazione, che punta a rassicurare la borghesia nostrana e le più preoccupate borghesie continentali come quelle tedesca e francese: in un contesto politico internazionale in cui la Francia e la Germania dovranno affrontare elezioni impegnative il prossimo anno, cambiamenti politici sgraditi nel Belpaese non sono certo i benvenuti. Con una crisi bancaria ancora irrisolta, di cui il MPS è solo la punta dell’iceberg, una crescita economica a dir poco anemica, elevato tasso di disoccupazione, deflazione persistente, salari stagnanti e precarietà dilagante, non è consigliabile assecondare chi il 4 dicembre ha espresso un chiaro atto d’accusa contro le politiche di un governo che, al netto di sparate propagandistiche anti-tecnocratiche poco credibili, è stato l’esecutore materiale di un tentativo di “modernizzazione neoliberista” dell’Italia per conto delle classi dominanti nostrane ed europee.
Gentiloni avrà senza dubbio il compito di provare a dare uno sbocco accettabile ai mandanti sociali di questa operazione, dilazionando le elezioni politiche e mettendo in campo una legge elettorale che scongiuri il ritorno a una qualche forma di proporzionale, visto come fumo negli occhi dalla borghesia, che invece ha bisogno di un assetto istituzionale che garantisca “governabilità” e impermeabilità ad ingerenze di istanze sociali contrarie ai suoi interessi. È però difficilmente ipotizzabile che le diverse forze politiche parlamentari si accordino su un’ipotesi condivisa di legge elettorale, dal momento che gli interessi a breve termine divergono sensibilmente e ciascuna è impegnata a promuovere lo sbocco più favorevole ai propri referenti sociali fondamentali e alle proprie ambizioni politico-elettorali, tutte comunque lontane dagli interessi delle classi popolari.
A tal proposito, la sentenza della Corte costituzionale il 24 Gennaio del prossimo anno segnerà indubbiamente un passaggio importante per gli esiti della legge elettorale, poiché è probabile che dal pronunciamento dell’organismo emerga un sistema di tipo proporzionale (sarà da verificare se alcuni aspetti maggioritari dell’Italicum saranno comunque raggiunti ma in modo costituzionalmente più accettabile, come ad esempio attraverso i collegi uninominali). A quel punto, tenendo conto delle modifiche già operate in senso proporzionalista al cosiddetto Porcellum dalla sentenza della Corte nel Gennaio 2014, basterebbe poco per armonizzare la legge della Camera a quella del Senato, con il risultato di un voto con un sistema sostanzialmente proporzionale, sebbene probabilmente non puro.
Una situazione di ulteriore incertezza è data dal quadro interno al Partito democratico, dove dal 18 dicembre si accenderà formalmente la resa dei conti interna con l’avvio delle procedure congressuali, in cui le diverse componenti ingaggeranno battaglia per il controllo del partito. La stessa scelta di Renzi di non dimettersi dall’incarico di segretario è indicativa dell’intenzione di questi di asserire il suo controllo e proporsi come candidato alle prossime elezioni (che non vorrebbe cadano troppo tardi) forte di una nuova investitura. Dall’esito di questo scontro dipenderanno anche in parte gli esiti della discussione parlamentare sulla nuova legge elettorale e sulla configurazione del quadro politico, giacché non è da escludere che una nuova vittoria (o sconfitta) del “ducetto di Rignano” possa causare rotture e ridefinizioni anche organizzative, che andrebbero potenzialmente a intrecciarsi con i travagli della cosiddetta “sinistra radicale”, dalla neonata SI al PRC.
Cos’ha tutto questo a che vedere con le chances che la nuova fase offre allo sviluppo di una politica radicalmente anticapitalista e di classe in questo Paese?
Molto, se partiamo dalla constatazione che il quadro politico in formazione è lungi dall’essere stabile, sarà attraversato da numerose contraddizioni (non ultima quella tra la necessità per le classi dominanti di una legge elettorale ipermaggioritaria e lo scenario concreto proporzionalista che potrebbe realisticamente verificarsi), e soggetto alle forti aspettative delle classi popolari, aprendo possibilmente spazi di intervento delle soggettività che operano su un terreno di classe.
Ma andiamo con ordine.
I flussi elettorali del No al referendum costituzionale ne dimostrano chiaramente il carattere di classe: il No stravince, con punte anche superiori al 70%, tra i giovani compresi tra un’età di 18 e 34 anni, tra i disoccupati e tra i soggetti con un reddito medio inferiore ai 16.000 euro annui, con una proporzione schiacciante al Sud del paese ma in modo sostanzialmente omogeneo sull’intero territorio nazionale (vedi l’elaborazione de Il Sole 24 Ore). Anche i dati delle singole città confermano la tendenza nazionale, laddove nei quartieri popolari il No prevale nettamente in contrasto con il voto nei quartieri agiati e borghesi.
In generale, l’esito del voto fotografa una realtà che poteva essere ignota solo a coloro che non riescono più ad avere il polso della società e degli umori che si agitano nella maggioranza sociale. Se si intrecciano questi dati, emerge senza ombra di dubbio che il voto referendario ha assunto una forte connotazione politica, oltre il contenuto del quesito sottoposto a referendum, con il rigetto delle politiche del governo Renzi nel suo complesso.
Jobs Act, Buona Scuola, Sblocca Italia, Legge Madia (poi bocciata parzialmente dalla Consulta), sono stati tra i provvedimenti più impopolari che hanno sensibilmente peggiorato le condizioni di vita e di lavoro di larghe masse nel paese, soprattutto di lavoratori e lavoratrici giovani, in un quadro di attacco generale all’intero mondo del lavoro. La retorica governativa, sostenuta da un bombardamento mediatico senza precedenti, si è infranta sul muro della realtà vissuta da milioni di persone, che hanno dimostrato un istinto di classe cristallino. Allo stesso modo, il Sì ha espresso plasticamente la prevalenza di interessi contrapposti, e i dati elettorali e la campagna forsennata condotta da padroni e padroncini, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, stanno lì a dimostrarlo.
Se questa è la caratteristica principale del No referendario, che conferma peraltro l’intuizione di chi ha contribuito alla campagna per il “No sociale”, nessun partito dell’arco parlamentare può legittimamente attribuirsi la paternità del voto poiché le motivazioni fondamentali della scelta della maggioranza degli elettori e degli elettrici appartenenti alle classi popolari, benché siano in parte sovrapponibili con quella della Lega e dei 5 Stelle nel rifiuto del governo Renzi, hanno espresso tuttavia una dinamica politica potenziale che eccede largamente le indicazioni di queste forze e che, come abbiamo visto, affonda le radici nella condizione di grave crisi sociale vissuta da questi settori maggioritari della società.
Ciò costituisce senza dubbio il fondamento non solo di una ripresa delle lotte e dei conflitti, ma anche di un rilancio dell’azione di soggettività di classe che possono legittimamente ambire a costruire in prospettiva un’opzione politica in grado di contendere lo spazio che si sta aprendo a forze che, come i 5 Stelle, sono al momento di gran lunga più attrezzate a raccogliere la domanda (e, ben inteso, solo la domanda) di opposizione allo stato di cose esistenti e di politica alternativa che proviene dai settori sfruttati e oppressi della società. Occorreranno presumibilmente tempi lunghi per risalire la china di una frammentazione, dispersione, limitata capacità di incidenza nel reale, frutto della sconfitta del movimento operaio e della provvisoria vittoria del suo antagonista storico, ma è importante attrezzarsi per sfruttare l’occasione che la situazione post-referendaria offre.
È del tutto evidente che il nuovo scenario necessiti di un salto di qualità di quella che per intenderci definiamo sinistra di classe, in primo luogo sul piano metodologico e di relazione.
La gravità della situazione impone di porre un termine a modalità non più adeguate ad affrontare positivamente le sfide che incombono, semmai lo siano state: aggregazione di ceti politici residuali, soluzioni imposte dall’alto e traghettate sui territori, sostanziale estraneità alle esperienze reali di scontro sociale e di classe, ricerca a prescindere di uno scranno nelle istituzioni capitaliste come unica certificazione di esistenza in vita. Tutte tare che puntualmente si ripresentano ogni qualvolta si senta il profumo di elezioni incombenti.
Per dirla con le parole di Antonio Moscato: «Non di unità indiscriminata di tutti c’è bisogno, ma di un’unità basata su esperienze di lotta e di resistenza, che escluda chiunque continua a impegolarsi nelle istituzioni partecipando ad alleanze interclassiste senza principi, gestendo alla meno peggio l’esistente». Ed è quindi la condivisione di pratiche e obiettivi il primo criterio in base al quale proporre un’unità più larga di tutte quelle forze che intendano opporsi al neoliberismo, al capitalismo e al vento di destra che soffia potente in Italia e in Europa.
Funzionale alla possibilità di questa unità è la capacità di mettere in piedi un vero e proprio network di militanti diffuso, articolato e plurale che sia in grado di ricostruire luoghi condivisi in cui condurre una discussione permanente volta alla pratica di esperienze comuni di resistenza alle politiche neoliberiste, a partire dal piano vertenziale. Esiziale a questa prospettiva sarebbe la riproposizione di modalità di relazione che più di una volta hanno favorito la rottura e la disgregazione di esperienze che pure avevano potenzialità importanti, impedendo di valorizzare a positivo le differenze: inutili diplomazie intergruppo, scarsa trasparenza nelle intenzioni di ciascun@, opacità delle divergenze, pratiche burocratiche e manipolatorie.
Ma c’è anche bisogno di un salto di qualità politico. È prioritario ripartire dai contenuti e non da improbabili contenitori. In realtà, il referendum del 4 dicembre ha già dato indicazioni importanti in tal senso: il chiaro rigetto nei confronti delle politiche sociali ed economiche del governo Renzi ha espresso un campo di forza che offre tutti gli elementi per rimettere a tema un programma politico di fase che affondi le radici nei bisogni negati di milioni di persone in questo paese, le quali hanno gridato a gran voce la voglia di una politica radicalmente diversa, che realmente migliori le loro condizioni di vita e di lavoro.
La sinistra di classe ha l’opportunità di dare forma a questo messaggio, convogliando le energie espresse il 4 Dicembre verso obiettivi chiari e comprensibili, in grado di stimolare l’entusiasmo, la partecipazione e l’autorganizzazione in prima persona dei soggetti sfruttati e oppressi:
- abolizione di tutte le leggi antipopolari del governo Renzi e dei governi precedenti
- forti investimenti per il rilancio della scuola e della sanità pubblica
- ripudio del debito illegittimo
- ripristino di una tassazione fortemente progressiva in cui chi ha di più paga di più
- ripristino ed estensione dello Statuto dei Lavoratori anche alle piccole imprese
- piano generale pubblico del lavoro, garanzia di reddito ai disoccupati e alle disoccupate
- riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario/stipendio e redistribuzione del lavoro esistente
- rigorosa applicazione dei principi di parità salariale tra le donne lavoratrici e gli uomini
- riduzione delle spese militari e patrimoniale sulle grandi ricchezze
- garanzia dei diritti di organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro
- fine delle grandi opere dannose per l’ambiente e costose
- piccole opere infrastrutturali diffuse a protezione dell’assetto idrogeologico del territorio piano organico per il potenziamento del trasporto pubblico, in particolare su rotaia
- nazionalizzazione senza indennizzo delle imprese che inquinano, che licenziano e delocalizzano
- creazione di una banca pubblica nazionale
Naturalmente è solo un esempio di programma possibile, che tenga insieme le necessità e le aspirazioni immediate di larghe masse con il progetto di una società alternativa al capitalismo. Un programma non è semplicemente una declamazione astratta di principi e obiettivi: è la mediazione politica delle istanze di trasformazione, una “bandiera piantata nella testa della gente”, per dirla con il vecchio Engels.
Il punto vero è ricominciare a discutere collettivamente di un programma adeguato al momento storico che stiamo vivendo e capire quale sia il veicolo organizzativo più utile a dargli corpo e sostanza, quale strumento prospettiamo a medio termine per ricostruire una capacità politica offensiva nel vivo dello scontro sociale, di classe e sindacale, che deve continuare ad avere un posto centrale (a tal proposito, un ottimo terreno di sperimentazione è il sostegno senza se e senza ma alla campagna per il No all’accordo dei metalmeccanici sottoscritto da Fiom, Fim e Uilm).
Se si continua a concepire che l’unione e l’estensione delle lotte metropolitane, per il lavoro, per il reddito, per servizi pubblici di qualità, gratuiti ed universali, per il diritto all’abitare, per l’ambiente e i diritti delle donne, avvengano spontaneamente, meccanicamente per aggregazioni successive o con la partecipazione reciproca dei e delle leader di queste lotte alle diverse assemblee, non si coglie il punto che la costruzione di un qualsiasi blocco sociale avviene per via essenzialmente politica. È l’attività politica che, tramite le parole d’ordine, struttura la relazione tra le domande sociali delle classi subalterne e la politica stessa.
Nel rifiuto sia dell’ “autonomia del politico” che dell’ “autonomia del sociale” c’è lo spazio della relazione dialettica di una efficace politica dei soggetti sociali sfruttati e oppressi.
È solo da queste premesse che ha senso affrontare il problema elettorale, che è elemento della politica generale delle classi subalterne, per chi si ponga in una prospettiva anticapitalista.
Si dice che la politica aborre il vuoto.
Realisticamente la sinistra di classe e i movimenti sociali in senso lato sono al momento incapaci di riempirlo, e non è da escludere che le classi lavoratrici dovranno fare esperienza e mettere a verifica altre opzioni politiche, il cui programma è al fondo espressione degli interessi di differenti classi sociali. Ma occorre prepararsi e farsi trovare pronti continuando a costruire adeguate capacità di organizzazione e di intervento nelle lotte di classe, nel movimento ambientalista e in quello femminista.
Se non cominciamo a farlo ora, quando i nodi verranno al pettine e le contraddizioni saranno ingestibili per chi sta in alto, sarà già troppo tardi.